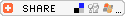Contenuto della pagina
Il paesaggio italiano

Il paesaggio rurale italiano è il risultato di millenni di storia in cui civiltà e culture diverse si sono succedute e intersecate nella sua struttura costituendone l'identità culturale. Non sarebbe possibile né corretto svolgere valutazioni e individuare misure per la sua salvaguardia senza tenere conto di questa profonda compenetrazione tra uomo e natura.
Ciò che distingue la complessità dei caratteri storici del paesaggio italiano, rispetto ad altri paesaggi europei, è la molteplicità e la stratificazione delle impronte che le molte civiltà che vi sono susseguite hanno lasciato nel territorio e nelle forme di boschi e campagne. Civiltà che hanno dato alle nostre campagne un grandissimo contributo specie vegetali, tecniche di coltivazione, modi di captazione e uso dell'acqua, costruzioni e manufatti, tanto da far assumere al paesaggio italiano un valore storico del tutto particolare rispetto agli altri paesi europei.
Una definizione
Il termine paesaggio deriva dal latino pagensis, aggettivazione di pagus, pietra di confine, villaggio, cioè parte di territorio naturale colonizzato e abitato dall'uomo, che lo localizza come proprio territorio. Il paesaggio non è l'ambiente naturale, ma è il luogo dove la storia umana si è sviluppata ed ha lasciato le sue tracce.
L'Italia ha la maggiore superficie coltivata fra gli stati dell'Europa a 15, circa 13 mila ettari, pari nell'anno 2001 al 43,8% di quella totale. Una superficie però in costante diminuzione, visto che negli anni '30 dello scorso secolo gli ettari erano oltre 26 mila, quasi il doppio, e che appaiono oggi distribuiti per il 45% in montagna, per il 23% in collina e per il 32% in pianura.
Il paesaggio italiano negli ultimi 150 anni ha subito molte trasformazioni che hanno modificato tutte le sue caratteristiche. Dopo una iniziale riduzione, dal 1920 ad oggi, l'estensione dei boschi italiani è quasi raddoppiata, mentre nello stesso periodo è stata persa circa la metà dei terreni coltivati. L'aumento del bosco è avvenuto soprattutto nelle regioni di montagna e collina, dove si trovavano il 68% dei terreni coltivati, con ben il 45% in montagna e si accompagna quindi ad un aumento delle specie vegetali a carattere forestale, associate ai sistemi naturali o seminaturali.
Il fenomeno è dovuto in gran parte all'abbandono delle montagne e delle campagne e alla riconquista di pascoli e campi da parte della vegetazione forestale. Le foreste italiane si trovano oggi in uno dei momenti di massima espansione rispetto agli ultimi due secoli e non sono in atto processi di deforestazione, che incidono in modo significativo sul trend nazionale. L'aumento dei territori riconquistati dai boschi è stato però accompagnato dalla semplificazione delle strutture forestali, dovuta alla sospensione della pratiche colturali tradizionali, e da una semplificazione del mosaico paesistico.
Le aree agricole sono state coinvolte da almeno tre grandi processi legati alla vegetazione forestale. Il primo è consistito nell'abbandono delle aree marginali, favorendo fenomeni di imboschimento spontaneo o artificiale e cancellando i paesaggi tradizionali preesistenti.
Il secondo è legato all'estensione delle monocolture con la creazione di grandi accorpamenti, a discapito degli elementi considerati inutili o di ostacolo alla meccanizzazione.
Un terzo fenomeno è stata la specializzazione delle colture che hanno sostituito le colture promiscue con impianti artificiali ad alta densità (es. oliveti, vigneti, frutteti) , o intensivizzato le colture su piccola scala (es. serre, colture orticole, vivai industriali). A tutto ciò si deve aggiungere la perdita di specie (animali e vegetali) associata ai sistemi agrari tradizionali.
Queste trasformazioni hanno anche inciso sulla sostenibilità energetica, nel passato legata al ricorso a risorse e processi endogeni (fissazione dell'azoto atmosferico, controllo biologico ecc.), creando paesaggi autonomi dal punto di vista energetico, in grado, nel caso di stress biotici o abiotici, di mantenere o recuperare facilmente le loro funzioni.
Le superfici a pascolo sono quelle che hanno subito la riduzione maggiore con la quasi totale scomparsa del pascolo arborato, che sussiste solo in alcune aree della Sardegna.
In generale si è assistito a una progressiva omogeneizzazione e semplificazione del paesaggio con una perdita dei caratteri "culturali" che lo hanno storicamente contraddistinto nel contesto europeo e mondiale. Nelle aree abbandonate o marginali, il paesaggio italiano assume caratteri più "naturali" grazie all'espansione dei boschi, nelle aree intensamente coltivate, invece, alla semplificazione spaziale si aggiunge quella degli ordinamenti colturali. Si tratta un processo che interessa non solo l'Italia, ma molti altri paesi europei e il Nord America, il ché conferisce al problema un carattere internazionale.